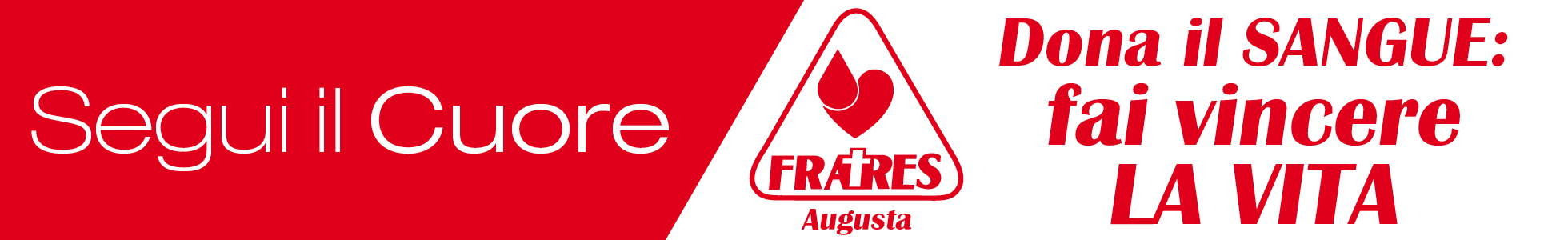Barbie il film, ricordare con gli occhi: le ragioni di un successo planetario

All’interno degli ampi discorsi sul film di Greta Gerwin resta, secondo me, un buco su un’importante questione tematica, che va al di là delle analisi sul film, il valore stilistico e la carenza di vernice rosa nel mercato globale: la spettatorialità femminile come conquista di uno spazio esclusivo. Per quel che mi riguarda, non è tanto il film Barbie in sé ad avere un valore nel dibattito quotidiano, quanto il film Barbie “fuori di sé”, per voler strizzare l’occhio al caro Hegel. Non tanto la trama, la struttura, i personaggi e il femminismo che il film pretende di veicolare sul grande schermo, quanto il fenomeno di “riappropriazione di uno spazio” che assume forma e coscienza al di qua dello schermo stesso.
Per comprendere questo passaggio è inevitabile e doveroso fare più di un passo indietro, seguendo le orme del cambiamento che attiene alla spettatorialità femminile nel tempo. Il rischio, altrimenti, è di non riuscire a comprendere alcuna “rivoluzione” o “conquista” e restare fuori da un dibattito che, a quel punto, resterebbe arginato nei confini di un giudizio parziale.
Negli anni ’60 una serie di eventi mondiali mettono in discussione l’esistenza delle cosiddette “grandi narrazioni”. Soprattutto le donne, attraverso i movimenti femministi, iniziano a rivendicare a gran voce il “diritto alla differenza” come valore fondante della società. Proprio le donne, infatti, smascherano il limite del lungo periodo caratterizzato dalle cosiddette “grandi narrazioni”, evidenziando come fossero legate a una visione strettamente maschile. Quello che stava accadendo era che dei singoli soggetti non si riconoscevano più dentro “racconti universali”, affermando il diritto alla differenza come principio fondante di un nuovo “io”. Pertanto, l’uomo, almeno concettualmente, inizia in quel momento a perdere la sua centralità: non è più colui che ordina il mondo e le donne lottano a favore di un decentramento del soggetto umano. La pluralità inizia a essere vista come una condizione essenziale.
Bene, facciamo a questo punto un passo in avanti e torniamo al discorso meramente cinematografico. Premettiamo che il piacere visivo nel cinema narrativo è dovuto al fatto che quest’ultimo è in grado di attivare il voyeurismo e il narcisismo. Il voyeurismo ha a che fare con il piacere di guardare qualcun altro che non sa di essere visto – quello spettatoriale è un piacere voyeurista – mentre quello narcisistico si attiva vedendo nel personaggio la propria immagine (immedesimazione). E qui giungiamo a un punto fondamentale: non si ha lo stesso piacere nello spettatore e nella spettatrice. Per esempio, il cinema classico rappresentava in modo diverso il maschile e il femminile, provocando di conseguenza una diversa esperienza in sala. Il piacere era stato ascritto all’uomo e non alla donna, distinguendo tra “attivo” maschile e “passivo” femminile. In altri termini, il piacere di guardare nel cinema classico non era destinato a tutti, proprio perché suddiviso in diversità di genere: il personaggio attivo nel guardare era quello maschile, il personaggio passivo, cioè il guardato, era quello femminile.
Quindi, nel cinema classico lo schema prevedeva che il soggetto maschile fosse quello attivo che guarda, mentre il personaggio femminile, quello passivo che viene guardato. Non solo, il personaggio maschile era quello che porta avanti la storia, mentre quello femminile paradossalmente la arresta: la sua funzione era di mero oggetto dello sguardo, ovvero attivare il desiderio maschile. In un film così strutturato, solo l’uomo è in grado di identificarsi col soggetto sullo schermo, mentre l’intero processo viene precluso alla donna in sala. È indubbia la perfetta sincronia tra realtà dentro la sala e realtà fuori dalla sala: il cinema replica una condizione consolidata nel quotidiano.
Cosa c’entra Barbie con tutto questo? Costruiamo ancora una base per la nostra riflessione. Sempre gli anni ’60, come abbiamo avuto modo di comprendere, hanno rappresentato un periodo di radicali trasformazioni, sia in ambito culturale che cinematografico: sono gli anni di Fellini, Visconti, Antonioni. Il critico Vittorio Spinazzola arriva addirittura a coniare il termine “superspettacolo d’autore” per definire un radicale cambiamento artistico-culturale, riferendosi in particolare alle pellicole “La dolce vita” di Fellini e “Rocco e i suoi fratelli” di Visconti. Si tratta di una trasformazione determinante, ma anche di un caso mai più replicato nella storia del cinema italiano, perché non è più successo che il cinema d’autore si trovasse in cima agli incassi. Anzi, poco dopo, si consoliderà una nettissima divisione tra “cinema alto” – con una scarsa presenza di pubblico – e “cinema basso”, caratterizzato da una narrazione popolare ancorata ai generi western all’italiana, commedia sexy, thriller, poliziesco.
Proprio Spinazzola mi ha portato a pensare Barbie come una sorta di “superspettacolo d’autore”, non perché si voglia paragonare il film alle pietre miliari felliniane e viscontiane, ma per quella sfumatura di significato che attiene al connubio tra spettacolarità e autorialità, con cui il nostro piglio critico fatica a fare i conti. Greta Gerwin, che di certo non è una regista improvvisata, dimostra di sapersi muovere nella fangosa terra di mezzo tra arte e industria, dove per “arte” intendo non tanto il valore del prodotto in sé, quanto la capacità di attivare un processo nostalgico nelle spettatrici in sala. Il passato, grazie al film Barbie, diventa un magma in eruzione capace di rompere gli argini di una stanzetta recondita e rivendicare uno spazio di appartenenza e competenza.
In tal senso, ci viene in aiuto la scrittrice e critica Natalia Ginzburg, che definisce il cinema come uno straordinario dispositivo memoriale, dove immagini sullo schermo e ricordi si mischiano fino a confondersi. Immagini e sogni sono fatti della medesima sostanza. Secondo Ginzburg, alcuni film, come per esempio Amarcord – secondo lei uno dei film più belli della storia del cinema – riescono a tradurre visivamente le memorie personali e collettive. Dice Ginzburg nel ruolo di spettatrice: “L’evocazione degli anni Trenta, in Amarcord, a me ha dato i brividi, perché mai mi era successo di vedere evocati gli anni della mia giovinezza, e il fascismo di allora, con tanta verità e orrore. Verità e orrore non sono enunciati né con parole né con avvenimenti, ma sempre e solo con un linguaggio di immagini. Di colpo, mi sono ricordata che quell’epoca era per me orribile. Lo sapevo, ma d’un tratto l’ho ricordato con gli occhi”.
Ora, è evidente che Ginzburg parla di un film che nulla ha a che fare con Barbie e cita, tra l’altro, un periodo storico fatto di orrore e assenza di umanità. C’è però un passaggio del suo discorso che trovo incredibilmente pertinente con questo ragionamento: “Lo sapevo, ma d’un tratto l’ho ricordato con gli occhi”. Oltre a essere una frase carica di bellezza è esattamente la chiave del “fenomeno Barbie”: tutte le donne sanno cosa abbia significato Barbie nella loro infanzia, ma improvvisamente lo hanno ricordato con gli occhi. Socialità, sogni, amicizie, progetti e storie venivano affidate a Barbie, e da lei realizzate. C’era la sensazione di possedere un luogo fortemente identitario in cui potersi ritrovare e riconoscere, ed era il luogo delle nostre storie, dove contava solo cosa noi avessimo da dire, da narrare, da fantasticare. Barbie era una sorta di alter ego che viveva in un mondo privo di confini: il mondo delle possibilità. Non si trattava solo di una bambola, quanto di una trasposizione materica della realizzazione dei sogni di ciascuna. Afferrandola e iniziando a giocare, tutto sembrava a portata di mano: l’Io-Barbie poteva diventare ogni cosa la nostra mente fosse in grado di pensare. E questo, dentro uno spazio in cui nessuno (!) poteva dire “questo non fa per te”, “non si addice a una femminuccia”, “è meglio che tu faccia altro”, “hai un carattere complicato”, “i sogni sono solamente sogni”.
Il mondo creato intorno a Barbie era la prima vera conquista di uno spazio esclusivo, da cui i maschi – già pieni di spazi esclusivi – restavano fuori. Attenzione però, per loro stessa scelta. La mancanza di strumenti e di codici di accesso verso quel mondo intessuto da piccole donne, fatto di trame e regole da loro stabilite, relegava il tutto a uno “stupido gioco” (un po’ come oggi relega il tutto a “uno stupido film”). Questo perché un mondo con regole stabilite dalle donne, fa ancora abbastanza specie.
Ripeto, non si disquisisce sulla qualità della pellicola in sé, quanto dei valori condivisi dal pubblico in sala: un pubblico di donne che fino a qualche decennio fa non aveva neanche il privilegio dell’immedesimazione in sala. Barbie, invece, permette al magma emotivo di esplodere con forza, rivendicando un mondo che, di fatto, appartiene a tutti. Anche alle donne. Barbie attiva ricordi legati alla capacità di fare squadra, alla complicità e alla creatività messa in campo per portare avanti una “narrazione comune”. E non importa se questa preveda un lieto fine, è il remare tutte insieme verso una direzione che conta.
È questo, secondo me, il passaggio chiave della spettatorialità in Barbie: attiva nel buio della sala, come i meandri di un sogno, la nostalgia di un tempo in cui tutto sembrava possibile e in cui piccole donne si scrivevano da sole la vita che avrebbero voluto vivere. In gruppo, poi, in una situazione di gioco condiviso, ogni bambina creava un tassello di storia, incastrando, pezzo dopo pezzo, una narrazione che diventava “costruzione solidale”.
Quella che alcuni vedono solo come una stupida bambola rappresenta una condivisone di intenti e la conquista di uno spazio. Tra l’altro, Ginzburg nei suoi scritti sul cinema, trasforma un dato empirico e personale, in un parametro estetico, trattando la memoria non solo come un mezzo per analizzare i film, ma anche come un criterio per esprimere un giudizio. Dice: “La memoria è l’unica vera chiave di giudizio per quanto riguarda i film. Di un film noi conserviamo unicamente quello che amiamo; tutto il resto si dissolve in cenere”.
Quindi, volendo cogliere la sua preziosa eredità, del film Barbie, ogni spettatrice conserva unicamente ciò che ama: la parte di sé bambina in cui quel mondo ludico era lo specchio di una identità autodeterminata. Tutto il resto si dissolve in cenere.
In ultimo, per concludere, quello con cui bisogna senza dubbio fare i conti, con buona pace di tutti, anche dei più critici, è che il cinema è industria, e come tale va anche inteso e interpretato. Pertanto, muovere una critica che miri a etichettare un film come “operazione di marketing”, apre due falle:
1. Il cinema è una industria e il marketing non può essere tenuto fuori (Barbie non è di certo il primo caso in cui si fanno operazioni di questo tipo). Soprattutto, se una industria guadagna, si traduce in termini di stipendi pagati e soldi rinvestiti (anche in opere dall’elevato valore artistico e intellettuale che però, ahimè, poi nessuno va a vedere).
2. Barbie ha rappresentato e rappresenta oggi attraverso il film in sala, la conquista di uno spazio esclusivo. Dove l’esclusività non è data dal chiudere la porta dall’interno, quanto dall’incapacità e dalla non volontà da parte dell’altro sesso di accedervi con rispetto e spirito di ascolto.
Il punto non è quanto sia rosa il mondo di Barbie, ma quanto questo colore desti ancora estremo disagio.