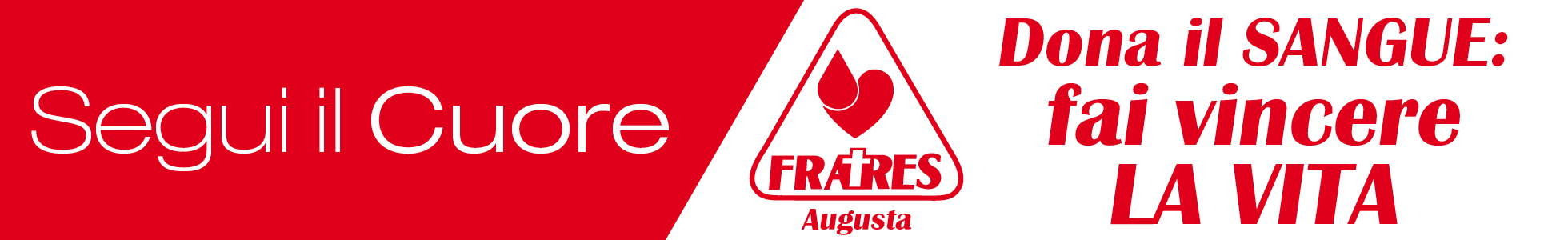Era d’estate. Una mattina, stavo per uscire per la mia solita lunga passeggiata a piedi in giro per la città. Ma appena uscito di casa, tutto quello che vedevo non corrispondeva ai miei ricordi: all’immagine dei luoghi che avevo prefigurata nella memoria, se n’era sovrapposta un’altra, offerta dagli occhi. Tutto era diverso, i palazzi, così come casa mia, erano spariti, sostituiti da piccole abitazioni di pietra.
Poi, posando lo sguardo sul mare, trasalii, rapito dall’immagine del maestoso castello, che altissimo e gigante si ergeva sul punto più alto dell’isola. Non l’avevo mai visto così bello, era florido, privo qualsiasi crepa e decorato di tutto punto, visibile anche da chilometri di distanza. Avvicinandomi, ne fui maggiormente impressionato: il mastio era monolitico e le torri si stagliavano al cielo.
Attraversati due ponti, la Porta di accesso all’isola era grandiosa, fatta di una pietra calcarea quasi diafana, con iscrizioni e stemmi lucenti. Intorno alla fortezza, numerose squadre di scalpellini stavano ultimando le mura della città, con blocchi imponenti che sembravano esser alte 100 metri. Il rumore del ticchettio di mazze e scalpelli risuonava cadenzato, ma allo stesso tempo un’atmosfera di mollezza pervadeva l’aria. Nel cortile del maniero, schiere di intellettuali, poeti, maestri e ciambellani rendevano vivido il luogo, sovrainteso dallo stupor mundi, Re Federico.
Un po’ più avanti, al centro dell’isola, un architetto dal cognome Juvara ultimava il suo capolavoro barocco, destinato a diventare chiesa delle Anime Sante, col prospetto convesso e l’elegante gioco di nicchie e decorazioni, spirali e palmette. Essa sembrava quasi specchiarsi nella chiesa di San Domenico, 150 metri più a Ovest, due piani più una torre-campanile di armoniche geometrie neoclassiche.
 Attorno all’isola, i bagnanti popolavano le coste, occupando ogni singolo lembo di spiaggia, ogni piccola insenatura: gli uomini pescavano del buon pesce, le donne prendevano il sole e i bambini giocavano sulla battigia.
Attorno all’isola, i bagnanti popolavano le coste, occupando ogni singolo lembo di spiaggia, ogni piccola insenatura: gli uomini pescavano del buon pesce, le donne prendevano il sole e i bambini giocavano sulla battigia.
Più a Ovest, dall’altra parte del porto megarese, la flotta greca era schierata. Trireme su trireme erano governate da uomini abili, pronti a partire per una nuova spedizione, mentre sulla terraferma, botteghe artigiane non smettevano la loro professione: chi modellava un vaso, chi fondeva una spada, l’altro cucinava il pane e l’agrimensore spartiva i rimanenti lotti tra i vari cittadini.
A un certo punto, alzati gli occhi al cielo, un dirigibile N2, allungato da far ombra, si apprestava al ricovero presso il grandioso Hangar, che da lontano appariva quasi come un Partenone moderno con tanto di timpano e muri della cella.
Augusta, insomma, non era mai stata così bella: importante il suo passato greco e grandiosa ai tempi di Federico, alchimia di natura e storia.