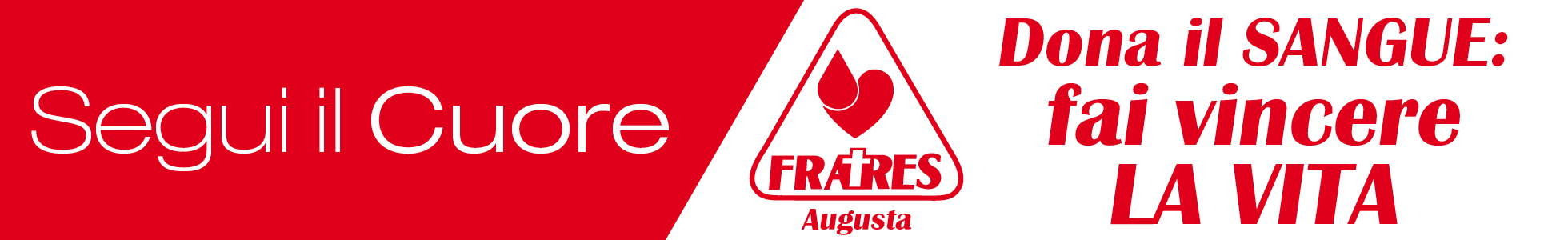Breve storia di Augusta: nascita della Città

AUGUSTA – Nell’ambito di una più ampia iniziativa editoriale promossa da La Gazzetta Augustana.it di divulgazione e promozione della storia di Augusta, abbiamo previsto una rubrica settimanale tematica nel nostro web magazine di approfondimento “Cultura”. Ha per titolo “Breve Storia di Augusta” ed è curata da Filippo Salvatore Lentini, detto Salvo, già ufficiale della Marina Militare, che da appassionato alle vicende storiche e alle tradizioni augustane, facendo ricorso ad un’estesa bibliografia che comprende i numeri del “Notiziario storico di Augusta” e i diversi lavori succedutisi nel tempo di noti studiosi della storia cittadina (che Lentini ci ha chiesto di menzionare in ordine casuale in premessa: Mario Mentesana, Elio Salerno, Tullio Marcon, Ennio Salerno, Vincenzo Vinciguerra, Ezechiele Salerno, Giorgio Casole, Sebastiano Salomone, Giovanni Vaccaro, Giuseppe Messina, Giovanni Satta, Giuseppe Carrabino, Italo Russo e non solo), ha pubblicato nel 2008 l’apprezzata opera dal titolo “L’Isola delle Palme”. Offrirà ai lettori de La Gazzetta Augustana.it, per la prima volta su una testata, la versione ridotta e adattata al web della sua pubblicazione.
1. Prologo – Nascita della Città.
Fra i popoli di navigatori, costantemente impegnati in lunghissime odissee attraverso i mari del Mediterraneo, vi erano i Megaresi che, provenienti dalla lontana Megara, situata nei pressi di Atene e dell’istmo di Corinto, approdarono nella poco accogliente Thapsos, l’odierna Isola Magnisi. In seguito, essi si spostarono verso la sponda occidentale dell’accogliente insenatura e alla foce dell’antico torrente Alabon, dove si formava un porto canale che favoriva il commercio marittimo: in questo sito, nel 727 a.c. fu fondata la città di Megara Hyblaea, che esistette per oltre cinque secoli. Distrutta una prima volta nel 483 a.c. dal siracusano Gelone e riedificata alla fine del quarto secolo a.c. dal re Timoleonte, fu nuovamente distrutta e bruciata nel 213 a.c. dal console romano Claudio Marcello, durante la lotta contro i Siracusani, nemici dell’Impero Romano. L’accenno alla presenza di Megara Hyblaea è fatto per dar spiegazione del perché tutto ciò che fa riferimento alla città di Augusta è denominato “Megarese”. Infatti, quando gli abitanti di Megara fuggirono dalla loro città in fiamme, molti di loro si rifugiarono nell’allora penisola, dall’altro lato dell’insenatura, dove sarebbe poi sorta la città di Augusta.
Deve trascorre un lungo periodo di “black-out storico”, per quanto riguarda lo “Scoglio” dove nascerà la città di Augusta, e bisogna arrivare ai primi anni del tredicesimo secolo per poter ricostruire l’andamento e gli avvenimenti che caratterizzarono la nascita della città. Dal diplomatico matrimonio celebrato nel 1186 fra Enrico VI, figlio di Federico I detto il Barbarossa, regnante della Casa Sveva nell’Italia meridionale, e Costanza d’Altavilla, figlia del normanno Ruggero II, nonché erede del Regno di Sicilia, il 26 dicembre dell’anno 1194 a Jesi, vicino ad Ancona, nacque il “nostro” Federico, ovvero il futuro Imperatore Federico II di Svevia. Nonostante la sua stirpe regale fosse d’origine tedesca, il giovane Imperatore si sentì innanzitutto italiano, e il Sud del paese fu il principale teatro della sua attività di sovrano e di condottiero. Nel 1250, quando le sorti delle varie battaglie sembravano volgere in suo favore e stava, dopo un periodo di insuccessi, riuscendo a far riprendere il volo alla sua “Aquila Imperiale”, il 13 dicembre, ancora agile e possente, dovette arrendersi alla morte: si trovava in terra di Puglia e mancavano pochi giorni al suo 56° compleanno.
Scritti storici, in verità pochissimi, assegnano ad Ottaviano Augusto il merito di aver fondato nel 42 a.c. la città di Augusta, che dallo stesso avrebbe preso il nome. Però nessun documento, attestante la certezza della fondazione da parte dei Romani, è mai pervenuto agli storici per poter accertare e confermare una tale versione dell’origine di Augusta. Fra l’altro, le continue e secolari scorribande delle orde barbariche avrebbero cancellato ogni segno o traccia della presenza di un’eventuale antica città esistente prima di quella fondata da Federico II. Quindi, si suppone che nell’era pre-federiciana lo “Scoglio” fosse quasi disabitato e vi vivessero, in piccole abitazioni, alcune famiglie di poveri pescatori, raggruppate in una sorta di “comunità sparsa”, ritenuti i probabili discendenti degli esuli di Megara Hyblaea. Pertanto, solo dall’inizio del 1200 sulla penisola si possono riscontrare i primi concreti segni di vita collettiva, accresciutasi sempre più a seguito della costruzione del castello e della nascita della relativa città, fortemente voluti da Federico II.
Con molta probabilità, in quegli inizi del Duecento, sullo “Scoglio” vi erano delle torri d’avvistamento o semplici rocche difensive, delle quali non se ne conosce la quantità e nemmeno l’esattezza dei siti; di una, in particolare, si sa che già esisteva nella parte Nord dell’allora penisola: quella edificata nel 1072 dai Normanni, intorno alla quale nel 1232 Federico II vi fece costruire il suo castello, che materialmente la incorporò. Dopo una decina di anni, su progettazione dell’incaricato Riccardo da Lentini, i lavori per la costruzione del castello, per i quali si sfruttarono le cave di pietra “giuggiolena” presenti nelle zone circostanti, furono completati; con esso si diede origine alla nascita di quella città che, col successivo sviluppo urbano, sarà la futura Augusta, la nostra “Isola delle Palme”. In seguito, l’Imperatore svevo fece tracciare le vie e gli edifici, con metodi e stili di forma simmetrica, tipica del periodo medievale, che ancora oggi si riscontra nel centro storico della città.
Se gli antichi Greci, per la loro tendenza di ricercare sempre luoghi abbastanza tranquilli e con delle risorse naturali, preferirono la pianura ricca di fertili terreni e la vicinanza di fiumi che garantivano lo sviluppo di una città dell’epoca, da parte sua Federico II, di questo splendido angolo di paradiso, scelse l’allora rude Penisola, della quale seppe ben valorizzare la naturale insenatura e la posizione strategica. Per realizzare il castello e nello stesso tempo popolare una nuova città, l’Imperatore vi fece deportare gli abitanti di Centuripe e di Montalbano, città distrutte perché ribelli alla corona imperiale, ed anche varie famiglie di Catania a lui particolarmente avverse.
Dopo gli Svevi, in Sicilia arrivarono gli Angioini che, in seguito alla lotta dei Vespri del 1282, vennero a loro volta estromessi dagli Aragonesi. Da allora iniziò un lunghissimo periodo di dominazione spagnola, che durò fino al 1713 quando, col Trattato di Utrecht, la Spagna venne estromessa dall’Italia e la corona di Sicilia fu assegnata a Vittorio Amedeo II duca di Savoia.
Salvo Lentini