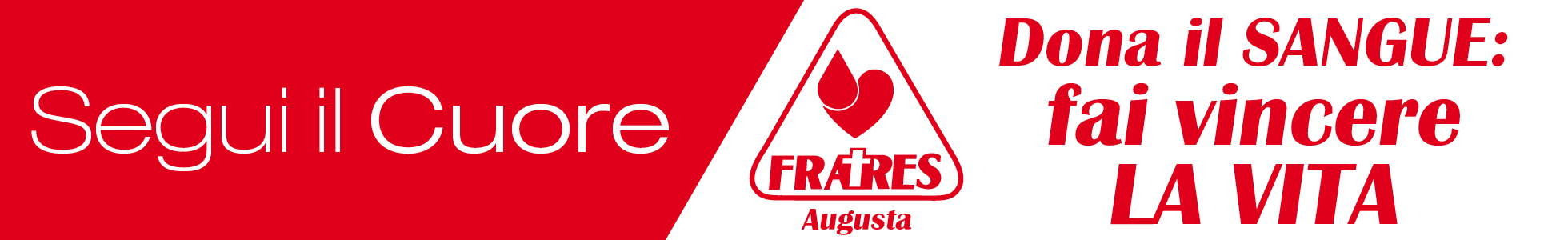Il cinema di Iñárritu: il cammino che conduce agli Oscar

All’indomani di una vittoria importante, quella del regista Alejandro González Iñárritu, anche per chi negli Oscar tiene conto dei numeri (un solo regista era riuscito a vincere per due anni di fila, ed è Joseph Mankiewicz che trionfò nel 1949 e nel 1950 rispettivamente con Lettera a Tre Mogli ed Eva Contro Eva), potrebbe risultare interessante capire chi è questo regista messicano e quale percorso l’ha condotto a queste vittorie.
Il cinema di Iñárritu inizia con quella che definirei la Trilogia del caso, accezione sotto la quale riunisco le tre pellicole Amores perros, 21 Grams e Babel, che pongono al centro della loro analisi il “piano dell’espressione”, cioè come l’oggetto si manifesta concretamente ai nostri occhi, che tipo di discorso si instaura con l’interlocutore/spettatore, attraverso quali mezzi lo fa e di quali strategie si serve (scarti temporali, flashback, flashforward…) per restituire determinate sensazioni.
Con la denominazione Trilogia del caso intendo una ideale trilogia sulla morte, sulla riflessione, sulla responsabilità e sulla compassione, che si apre con Amores perros (che punta l’attenzione su una cinematografia a volte poco tollerata e ancor meno distribuita, riuscendo, così, a colpire la critica mostrando una difficile, inquietante e adrenalinica Città del Messico raccontata con la crudezza che viene fuori dai personaggi, dai cani reali e metaforici e dall’ambiente dei combattimenti), che prosegue con 21 Grams (caratterizzato dalla frammentazione e ricomposizione di una “geografia umana” resa spezzando la continuità cronologica, illustrando prima gli effetti delle cose e giocando sui diversi angoli della costruzione narrativa) e che si chiude con Babel (la formula è sempre la stessa: storie, personaggi e destini che si incrociano in un film sull’incapacità di amare e trasmettere amore dove la miseria e l’empatia fanno da unione tra i personaggi, in cui compare un Iñárritu più politico che critica la ferrea burocrazia degli Stati Uniti nei confronti delle persone messicane, la rigida e ottusa testardaggine delle forze dell’ordine, le aberrazioni giovanili dell’occidentalizzazione giapponese).
Immagino questa prima fase della cinematografia di Iñárritu caratterizzata da queste tre pellicole, come un cerchio che si apre con Amores perros e che si chiude con Babel, in cui emerge la forte idea del regista messicano e del suo sceneggiatore Arriaga che siamo tutti connessi gli uni agli altri. In Amores Perros, infatti, c’erano tre storie che si incastravano in un unico punto, ovvero l’incidente, mostrato nei tre diversi punti di vista; in 21 Grams c’era una sola storia narrata da tre differenti punti di vista, in cui i personaggi venivano uniti da un incidente che però a differenza del primo film non viene mai mostrato; in Babel, invece, ci sono quattro storie diverse e i personaggi non si incontrano mai fisicamente ma, ciò nonostante, sono tra loro strettamente legati a livello emotivo.
Dunque, una trilogia che si apre verso il mondo: Amores Perros era legato ad un contesto e una prospettiva locale (il Messico), 21 Grams estendeva lo sguardo agli Stati Uniti, con Babel Iñárritu conclude con una visione più globale che racchiude in sé differenti culture, legate tra loro da un minimo comune denominatore dell’umanità che è la sofferenza. La tecnica narrativa segue in tutti e tre i film la struttura a mosaico in quanto, come ha spiegato lo stesso regista, la frammentazione e la frammentarietà sono caratteristiche delle nostra vita dove tutte le tessere si incastrano in una trama di collegamenti. L’intricato sistema ad incastro dei plot narrativi è una dimensione a cavallo tra la sceneggiatura di Arriaga e la regia di Iñárritu, che dà come risultato ultimo una orchestrazione di eterogenei materiali e temporalità. La scrittura di Arriaga è una scrittura corpo che si insidia nello sguardo dello spettatore e che mostra in qualche modo il concetto stesso di uomo che appartiene allo sceneggiatore: l’uomo è corpo e mente; quando è corpo diventa carne ed è destinato a marcire e cadere a pezzi, scindendosi dallo spirito e unendosi alla terra, quando è mente diventa pensiero, ostinazione, desiderio ed è portato ad elevarsi allontanandosi dalla terra e dal dolore della sofferenza.
La sceneggiatura di Arriaga si fa poi immagine grazie al regista messicano che propone squarci di realtà urbana e di vita concreta a volte colte nel loro grigiore e nella loro stanchezza grazie anche alla fotografia di Rodrigo Prieto, opaca e livida, e all’utilizzo della camera a mano che dà allo spettatore una sensazione di infermità e precarietà. Con Amores Perros Iñárritu si è fatto conoscere dal pubblico internazionale: risulta essere infatti il miglior esordio alla regia tra il 2000 e il 2001. Ricevendo più di sessanta riconoscimenti, il film è stato tra i più premiati nella stagione. Anche con Babel riceve premi e nomination in tutto il mondo e proprio grazie a quest’ultimo film Iñárritu diventa il primo regista messicano candidato agli Oscar.
Nato a Città del Messico nel 1963, Alejandro González Iñárritu, insieme ad Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro è uno fra gli esponenti di punta del gruppo di cineasti messicani affermatisi a Hollywood. Rotto il sodalizio con lo sceneggiatore Arriaga, arrivano gli anni della maturità di Iñárritu. Nel 2010 firma Biutiful, film in cui si libera degli slittamenti temporali e degli incastri narrativi, portando sullo schermo una storia tanto lineare quanto complessa e profonda. È come se l’anello che Uxbal dona all’inizio del film (si scoprirà molto più tardi a chi), affermandone l’autenticità a dispetto di quello che ne ha detto la moglie, fosse un patto con lo spettatore. Grazie al corpo/immagine di Javier Bardem, Iñárritu ci costringe a guardare il dolore e a condividerlo. Dice il regista stesso: “Nei miei film è costante la rappresentazione della sofferenza per rendere poi maggiormente quella della felicità e dell’ingiustizia e per accentuare l’attaccamento a ciò che è giusto“.
Il resto, forse, è una storia più conosciuta, è quella che consacra Iñárritu tra i grandi del panorama cinematografico contemporaneo: Birdman e Revenant. Birdman rappresenta l’incontro ed inevitabile scontro culturale tra un cinema cosiddetto blockbuster e un certo cinema d’élite, tra ciò che può essere considerato degno e ciò che è “di massa”. Conflitto, questo, che spesso ha portato a definire dei ruoli: il teatro per intenditori-colti e il cinema per il popolo da intrattenere (ruolo oggi ricoperto dalla televisione). Questo pensiero si concretizza nel personaggio della critica teatrale, che dichiara di voler distruggere lo spettacolo messo su dal protagonista, Riggan Thomson, poiché egli è esattamente quanto detto: la sporca popolarità data dal mainstream che nulla ha a che vedere con il prestigio (ben sottolineato dalle battute “la popolarità è la cugina troia del prestigio“).
La critica è quell’autorità che permette di elevare o distruggere, quel credito dato da una firma-prestigio che può mettere il timbro d’approvazione su un prodotto: si può considerare o non si può considerare arte. Il cinema è di per sé denominato la settima arte, ma, volendo strizzare l’occhio a Manzoni, basta entrare dentro lo statuto dell’arte affinché “merda d’artista” venga considerata somma arte alla pari della Venere di Botticelli? Questo conflitto tra accettazione di sé come artista e affermazione di sé come uomo di successo la fa da padrona lungo tutto il film attraverso il conflitto del protagonista che appare letteralmente scisso tra l’Io attore-artista-talento e “l’Uber-Ich”, il super-Io Birdman-popolarità-denaro. Molto si potrebbe scrivere su Birdman (per il quale mi propongo di pubblicare una recensione), che ha conquistato agli Oscar 2015 Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior fotografia, non solo per la ricchezza di analisi che il film offre ma anche perché senza ombra di dubbio rimane il miglior film di Iñárritu.
L’ultimo film, Revenant, ha appena conquistato Miglior regia, Miglior fotografia, Miglior attore protagonista dove, al di là degli aspetti simbolico-narrativi su cui si potrebbe approfondire molto, rimane portante la grandiosità degli effetti visivi, grazie anche ad una fotografia quasi da pittura su tela caratterizzata dal girare solo con luce naturale (geniale Emmanuel Lubezki che vince l’Oscar per il terzo anno consecutivo) e agli effetti tecnici che rendono scene come quella della lotta con l’orso veramente da manuale. Girato in condizione estreme, Revenant, con l’ossessione del realismo più vero, con effetti che rendono reale e tangibile anche ciò che non lo è, in cui la natura si fa protagonista irrompendo sullo schermo nel suo essere selvaggia e incantevole.
Il cinema di Iñárritu si colloca all’interno di un panorama, quello messicano, tutt’oggi ancora difficile e complesso, in cui il regista, insieme ai suoi colleghi Alfonso Cuarón e Guillermo Del Toro, ha collaborato ad accendere i riflettori su una situazione e una città controversa, dove la mancanza di volontà politica di appoggiare la produzione nazionale continua a contrastare con la retorica trionfalistica che insiste nel celebrare i successi ottenuti dai tre cineasti messicani. I quali, non trovando condizioni propizie per fare cinema con continuità nel loro Paese d’origine, hanno deciso di lavorare all’estero. Iñárritu rimane, però, legato e al suo Paese, tanto che l’anno scorso durante il ritiro della statuetta ha fatto riferimento a un tema a lui caro: la frontiera, l’immigrazione, il rispetto. Iñárritu si muove all’interno del cinema americano conservando saldamente una forte etichetta personale. Un piede dentro e uno fuori, un cinema che non è del tutto americano ma neanche europeo; un cinema liminale come la frontiera: terreno di confine che fa essere dentro e fuori, di tutti e di nessuno e che forse più di ogni altra cosa traccia l’identità di un “io” che rivendica la propria identità.